

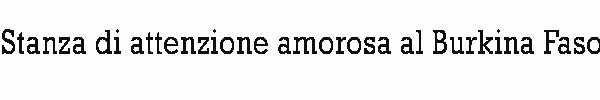
DA "AFRICA", FASCICOLO MONOGRAFICO BILINGUE (ITALIANO E INGLESE) DI "LEGGENDARIA", NN. 55-56/2006 - Il fascicolo può essere acquistato in rete dal sito www.manifestolibri.it (vai su "Collane", vai su "Rivista Leggendaria")
La libertà della lingua che svela
menzogne
Silvia Riva
Dal 2004
esiste sul web una base dati lessicografica, la BDLP[1],
che è nel contempo un dizionario enciclopedico delle varianti del
francese nel mondo francofono e una miniera di informazioni sull'evoluzione
della lingua. E' costantemente aggiornata e molto attenta alle espressioni
dell'oralità. Una ricognizione anche sommaria delle voci ci direbbe
che in Acadie (una regione canadese che si affaccia sull'Atlantico) quello
che in Francia è chiamato nombril (ombelico) diventa berlicoco;
che un po' più a ovest, in Québec, parler à travers
son chapeau significa parlare senza cognizione di causa; che in Africa
centrale un père in termini ecclesiastici è sempre un Père
blanc, mentre un sacerdote africano è piuttosto un abbé;
che nell'isola di La Réunion sono ancora in uso parole francesi
(per lo più appartenenti all'area della Normandia) che sono scomparse
nell'Esagono ormai dal XVII secolo. Il fatto è che nel mondo circa
250 milioni di persone parlano, leggono o capiscono a livello più
o meno fluente l'idioma di Montesquieu, il che fa del francese la nona
comunità linguistica al mondo, ma la sola, con quella anglofona,
ad essere presente su tutti i continenti.
E' questa caratteristica di diffusione capillare in ogni area del globo
che rende interessante tanto l'uso della lingua parlata (molte volte ereditata
da un passato coloniale, ma spesso anche scelta come lingua di elezione),
quanto l'uso della lingua scritta, quella letteraria, eletta a codice
di espressione artistica da autori diversissimi per gusto, immaginario,
stile, origine, tradizione, realtà, vissuto; insomma, per spazio
mentale e fisico. E spesso ognuno di loro è la somma di una grande
quantità di sostrati che, a loro volta, si sovrappongono, dando
luogo a quello che il caraibico Edouard Glissant chiamerebbe un prodotto
della "creolizzazione", ossia della messa in relazione inaspettata
e dell'incontro (che non si riduce mai a pura sommatoria) di radici multiple[2].
Prendiamo, ad esempio, la grande scrittrice e saggista nata a Orano nel
1937, Hélène Cixous, che si autodefinisce (in inglese) in
questo modo: "I was born in Algeria, and my ancestors lived in Spain,
Morocco, Austria, Hungary, Czechoslovakia, Germany; my brothers by birth
are Arabs. So where are we in History? [...] What is my name? I want to
change life. Who is this "I"? Where is my place? [...] Which
language is mine? French? German? Arabic?"[3].
Eppure Hélène Cixous ha espresso le teorie femministe più
convincenti in lingua francese, nei romanzi Dedans (1969), Le troisème
corps (1970), Illa (1980) e Manne (1988), Osnabrück[4](1999)
; a teatro con Portrait de Dora[5](1976),
La prise de l'école Madhuba? (1983) e L'indiade (1987); nelle poesie
contenute in Un vrai jardin (1971) e Souffles (1975); e ancora in La jeune
née (1975), La venue à l'écriture (1977)[6],
Jours de l'an (1990), L'ange du secret (1991), Déluge (1992), Messie
(1996), Or: les lettres de mon père (1997)…
Perché, allora, scrivere proprio in francese? Non certo, come sostiene
con ironia lo scrittore originario dell'enclave francofono di Gibuti (Corno
d'Africa), Abdouarahman A. Waberi, <<pour faire rager la perfide
Albino>>; e nemmeno - lo afferma con altrettanta ironia - perché
si è un <<ardent défenseur de l'exception culturelle
française>> (espressione vuota, che è servita più
sul piano politico e economico che non su quello propriamente culturale).
La prima risposta (anche se, come vedremo, non è la sola) risiede
piuttosto nel fatto che si è <<un pur produit postcolonial>>[7].
E ciò ci rimanda immediatamente al prima del "post",
ossia alla colonia.
Quante volte gli scrittori cosiddetti "francofoni", nati e cresciuti
in epoca coloniale in Maghreb, in Africa sub-sahariana, nei Caraibi, in
Indocina o alle Comore, ci hanno ricordato che quando a scuola cominciavano
a studiare storia, i loro libri di testo esordivano con la frase, quanto
mai paradossale,"Nos ancêtres, les Gaulois". In quel contesto,
lo studio del francese (della sua storia, ma anche della lingua e della
letteratura) ha pertanto avuto un enorme potere seduttivo (in senso strettamente
etimologico) sui giovani discenti, futuri scrittori. Torna in mente una
delle pagine più famose di uno dei romanzi più celebri dell'Africa
nera francofona, quello del senegalese Cheikh Hamidou Kane, L'Aventure
ambiguë (1961)[8],
dove si dice che se la Francia ha "vinto" in Africa senza avere
ragione, non è stato certo per i cannoni, quanto piuttosto per
il potere persuasivo, magnetico esercitato dalla scuola. Alain Mabanckou,
uno dei narratori della nuova generazione (è nato nel 1966) e fra
quelli oggi più in vista, ha ribadito questo concetto pochissimi
mesi fa: <<J'écris en français parce que c'est avec
cette langue que j'ai découvert les mots. C'est avec elle que je
l'ai emporté sur un ami lorsque nous courtisions la même
copine au collège, lui le faisait en langue, moi je convoquais
Lamartine, m'appuyais sur Verlaine ou interpellais Ronsard. Avec le français,
j'ai réalisé que la parole, la pensée, l'imaginaire
pouvaient être marqués. Que l'émotion n'habite pas
que la voix, mais aussi une page peuplée de signes. J'écris
en français parce que c'est en français que j'ai pour la
première fois lu et commencé à voyager à travers
ces lectures…>>[9].
Mabanckou fa eco a un suo compatriota altrettanto famoso, Henri Lopes,
che in un saggio intitolato proprio Ma grand-mère bantoue et mes
ancêtres les Gaulois. Simples discours (2003), torna sul tema del
potere attrattivo del francese, che è usato non tanto perché
è parlato nel mondo (anzi, ricorda Lopes, <il y a plus d'individus
qui s'expriment en chinois, en hindi ou en bahasa Indonesia qu'il n'existe
de francophones sur toute la planète>>), ma perché
<<il existe des nuances de la pensée, d'expression des sentiments
et du goût qui ne peuvent bien s'exprimer que dans cette langue>>[10].
Dunque un matrimonio perfetto quello fra scrittori francografi e lingua
dei Galli? Per niente: tanta, tantissima strada è stata percorsa
perché si potesse arrivare oggi a dirsi (e forse a sentirsi) totalmente
affrancati da quelle "marques", da quelle cicatrici o da quei
segni identitari percepiti come stranieri ed estranei, che per lungo tempo
hanno costretto gli scrittori a fare i conti non soltanto con il codice
linguistico, ma proprio col suo potere seducente.
Pensiamo innanzi tutto ai pionieri. Amadou Hampaté Bâ, il
tradizionalista maliano noto per aver sostenuto che <<quando in
Africa un vecchio muore è come su bruciasse un'intera biblioteca>>,
nel suo unico romanzo L'Etrange destin de Wangrin (1973)[11],
usa una gustosa espressione per indicare chi, in epoca coloniale, sapeva
scrivere e parlare in francese corretto: quel francese è per lui
<<couleur vin de Bourgogne>>. E il suo romanzo - apparentemente
semplice, ma estremamente complicato, come quasi tutti i romanzi africani
sanno essere - è in effetti scritto in modo da rispettare in modo
assolutamente corretto la lingua standard: se ci sono intrusioni di termini,
espressioni, parole prese a prestito dal suo peul natio o da altre lingue
africane, Hampaté Bâ si premura immediatamente di mettere
una nota a pie' di pagina per spiegarne il senso all'ignaro lettore (che
si suppone invariabilmente francese). Premura da filologo o da tradizionalista?
Direi che Hampaté Bâ è stato e ha voluto essere innanzitutto
un passeur di culture. La sua esigenza di chiarezza è pari al suo
desiderio di condivisione e di messa in comune. Aggiungo che il suo romanzo
si situa interamente in epoca coloniale e narra l'irresistibile ascesa,
seguita da un'altrettanto vertiginosa caduta, di un interprete che approfitta
del suo ruolo di mediatore culturale, oltre che linguistico, per trarre
vantaggio da quella posizione privilegiata. La riflessione sull'uso e
sulla manipolazione della lingua è quindi preminente nella letteratura
africana francofona fin dalle origini.
Che menzogna e lingua abbiano molto in comune ce lo ricorda Harald Weinrich
in Linguistik der Lüge[12]:
lo studio della letteratura è, come richiama ancora Alain Ricard,
innanzitutto lo studio delle convenzioni e delle istituzioni che costituiscono
il sottobosco di qualsiasi creazione verbale[13].
Quando le convenzioni saltano, anche la lingua può pertanto ambire
alla libertà, magari per denunciare proprio nuove menzogne. E'
il caso del celeberrimo uso della lingua francese operato per la prima
volta da Ahmadou Kourouma in Les Soleils des Indépendances (1968)[14].
In questo caso calchi e prestiti morfo-fonologici contraddistinguono l'opera
fin dal titolo: nessuno in Francia per dire "epoca" avrebbe
usato la parola "soli", come invece accade nella lingua malinké
(la lingua d'origine dell'autore ivoriano). Spesso si è detto che
Kourouma, per stigmatizzare le Afriche delle Indipendenze e delle dittature,
ha fatto ricorso alla "malinkisation" del francese o alla ibridazione
della struttura romanzesca (come è il caso per il romanzo del 1998
En attendant le vote des bêtes sauvages, in cui Kourouma riversa
il respiro dell'epopea nello stampo del romanzo balzachiano, combinando
estetiche che hanno visioni opposte e rivolte ad un pubblico, questa volta,
eterogeneo). Con lui, e negli anni successivi, il "vin de Bourgogne"
diventa decisamente sempre più scuro.
Ancor di più lo sarà negli anni Ottanta. Certo, non sempre
e non ovunque. E ipotizzo qui che più la materia di cui uno scrittore
intende trattare sarà delicata per tema e per valenza politica,
più la lingua si farà complessa e stratificata. Penso, in
particolare, a Le pacte de sang[15],
un romanzo uscito nel 1984 nello Zaire (ora Repubblica Democratica del
Congo), dove si parla di traffico d'organi, di violenze arbitrarie, di
soprusi del potere in una città retta dai "Seigneurs de la
forêt", esponenti di una delle dittature più longeve
e crudeli del continente, quella di Mobutu: nelle pagine moltissime parole
in lingua cilubà non sono affatto tradotte e nemmeno contestualizzate.
Chi abbia intenzione di capire in modo univoco di cosa si tratti deve
accedere ad alcuni gradi di approfondimento - attingibili grazie alla
lettura non solo di questo romanzo, ma di un vero e proprio ciclo/trilogia
-, che sono caratteristici non solo della lingua/scrittura africana, ma
anche dello stile di molti narratori africani e caraibici: la possibilità
di iterare segni ed enunciati, la dialettica fra la libertà creatrice
innovativa e uno stile collettivo predeterminato e codificato. Per quanto
riguarda i Caraibi, poi, l'uso sempre più invasivo del creolo risponde
a una lunga strategia di (ri)appropriazione. Come ha osservato Milan Kundera
a proposito del romanzo Texaco (1992)[16],
Patrick Chamoiseau <<n'a pas fait un compromis entre le français
et le créole en les mélangeant. Sa langue, c'est le français,
bien que transformé; non pas créolisé (aucun Martiniquais
ne parle comme ça) mais chamoisisé>>[17].
Il "pensiero della traccia", caro a Glissant, ha fatto il suo
corso.
Tre vie dunque per gli scrittori nati in epoca coloniale per usare una
lingua che ha fatto irruzione in casa loro senza essere stata invitata:
il rispetto impacciato (ma spesso anche ironico) degli scrittori pionieri,
il compromesso che maschera diffidenza e menzogna tanto verso il passato
coloniale quanto verso un futuro frequentemente neo-coloniale, la netta
separazione fra ciò che può essere inteso da tutti e l'inaudito
(delle dittature e delle violenze), che non trova parole per essere espresso
in più di un modo - e anche quello appare inadeguato.
Infine, un fenomeno poco consueto in ambito francofono e che comincia
solo ora a farsi strada: quello del rispetto reciproco nelle proprie,
rispettive libertà, ovvero lo spazio della traduzione. Ci sono
voluti cinquant'anni, ma ora l'opera del ruandese Alexis Kagame che, pur
conoscendo perfettamente il francese, preferì scrivere in lingua
kinyarwanda, è stata finalmente tradotta e non da lui[18].
Degli scrittori più giovani, puri prodotti della "post-colonie"
che qualcuno ha anche maldestramente chiamato esponenti della "migritude"[19],
si è già detto. Nessuno si preoccupa più del francese
come di una "lingua madre" da cui prendere le distanze o a cui
rifarsi. Si può dire che ora è proprio il francese ad essere
diventato - come afferma con un'espressione molto azzeccata la giovane
scrittrice camerunese Léonora Milano[20]-
"bottino di guerra". Nimrod, nato in Ciad nel 1959, afferma
al proposito che <<écrire, c'est exactement cela: non pas
être materné, mais devenir pour soi-même la mère
de sa propre langue. Pour s'accaparer le monde, rien ne vaut la puissance
de forage des langues. Laissons la Bible à un certain imaginaire
occidental le mythe de la dispersion des langues. Pour nous, elles ne
furent jamais que des agents fédérateurs. Quoi que fasse
un écrivain, son œuvre ressemblera toujours à la maçonnerie
superbe et parfaite, qui le défie, lui, ainsi que les êtres
de chair et d'os parmi lesquels il continue de vivre>>[21].
Ed ecco allora moltiplicarsi strati e strati di materiali di recupero
veramente disparati: spesso ciò accade soprattutto nel romanzo
giallo, dove al francese di Parigi (addirittura di quartieri ben definiti),
si sovrappone il verlan della malavita, il lingala centrafricano, il wolof
senegalese e altre diavolerie che hanno inventato proprio oggi, mentre
state leggendo, nelle strade di Kinshasa, di Bruxelles, di Montréal
o di Cape Town[22].
Un caso del tutto diverso tocca chi, come gli scrittori risparmiati dal
trauma della colonizzazione, hanno scelto di esprimersi in francese.
Penso innanzitutto ai Quebecchesi, per i quali il rapporto con la lingua
madre è il più antico (risale al XVI secolo) ed è
stato molto complesso, all'insegna del desiderio, da una parte, e del
rischio continuo di perdita (tenuto sotto costante minaccia dall'imperativo
"Speak White!" che i cugini anglofoni non mancavano di ripetere).
Sarebbe impossibile ripercorrere in poche righe la storia del rapporto
assai complesso con la lingua francese e che, forse, potrebbe riassumersi
in una battuta prendendo a prestito il titolo di una famosa canzone, "Je
t'aime, moi non plus". Oggi, che si tratti di poesia (Jacques Brault,
A.M. Klein), di romanzi (Nicole Brossard, Jean Forest, Daniel Gagnon,
Monique LaRue, Francine Noël, Jacques Poulin, Régine Robin)
o di teatro (Marco Micone, Robert Lepage), tutto è fatto all'insegna
della molteplicità, dell'intertestualità e dell'incontro
di parole dell'altrove e del qui, poiché il Canada francofono -
si dovrebbe parlare di eccezione culturale canadese? - è terra
di approdo felice della diaspora (haitiana: Emile Ollivier, Dany Laferrière;
indiana algonchina: Bernard Assiniwi, e poi africana, maghrebina, italiana…)[23].
L'altro caso, col quale concluderò questa breve panoramica, è
quello di chi ha scelto di esprimersi in francese pur non condividendo
con la Francia né un passato coloniale, né un destino storico.
Molti di loro hanno appreso il francese in tarda età. Penso al
greco Vassili Alexakis (classe 1943), alla cinese trapiantata a Vancouver
Ying Chen, all'iraniana Chahdortt Djavann, al russo Andreï Makine
(rifugiatosi in Francia nel 1987) e di cui Tatyana Tolstava, in The New
York Review of Books, ha scritto: "La letteratura russa può
vantare uno strano successo: Andreï Makine, un russo di indeterminate
origini francesi, ha ricevuto due dei più prestigiosi premi letterari
per un libro scritto in Francia, in francese e riguardante la Francia
- un libro che è, nonostante tutto ciò, la quintessenza
della Russia".
Penso ancora al libanese Percy Kemp, nato nel 1952 a Beyrouth dove vive
tuttora, che ci ricorda - come molti altri degli scrittori appena citati
(e ne mancano molti all'appello) - che il francese è stato per
lui la lingua della riflessione e della distanziazione. Una lingua che
ha consentito a molti di loro di crearsi uno spazio di libertà.
In fondo, come ha affermato Roland Barthes, la letteratura è "cette
tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique, qui permet d'entendre
la langue hors-pouvoir, dans la splendeur d'une révolution permanente
du langage"[24].
Così, giocando un po' con la lingua e chiudendo quasi da dove siamo
partiti, lascio di nuovo la parola a Abdourahman A. Waberi che, alla domanda;
"Perché ha deciso di scrivere in francese?" risponde:
<<J'écris en français parce qu'il faut rendre à
Césaire ce qui lui revient>>.[25]
[1] http://www.tlfq.ulaval.ca/bdpl/default.asp
[2] Edouard Glissant, Poetica del diverso, Roma, Meltemi, "Gli Argonauti",
1998.
[3] Hélène Cixous, The Newly Born Woman, Minneapolis, University
of Minnesota Press, 1986, p. 71.
[4] Osnabrück. Traduzione di Monica Fiorini, Ferrara, Tufani, 2001.
[5] Ritratto di Dora. Traduzione di Luisa Muraro, Feltrinelli, Milano,
1977.
[6] La venuta alla scrittura. Traduzione di Monica Fiorini, "Studi
di estetica" (17, 3, 1998), p. 7-53.
[7] Abdouarahman A. Waberi, "Parce que je suis un pur produit postcolonial",
in Libération, Supplément au n° 7730, jeudi 16 mars
2006, p. 7. Di A. Waberi sono state tradotte in italiano le seguenti opere:
Mietitura di teste. Pagine per il Ruanda (Moisson de crânes, Textes
pour le Randa, 2000) a cura di Marie-José Hoyet, Roma, Edizioni
Lavoro, "L'altra riva", 2001; Balbala (1998), Roma, Edizioni
Lavoro, "L'altra riva", 2003 (a cura di Marie-José Hoyet);
Transit (2003), Milano, Morellini, "Griot", 2005 (traduzione
di Antonella Belli).
[8] Tradotto in Italiano con il titolo L'ambigua avventura. Prima edizione:
Milano, Jaca Book, 1979. Riedizioni: Jaca Book, 1995; Jaca Book, "Mondi
letterari", 1996.
[9] Alain Mabanckou, "J'interpellais Ronsard pour faire la cour",
in Libération, Supplément au n° 7730, jeudi 16 mars
2006, p. 10. Tra i romanzi di A. Mabanckou, non ancora tradotti in italiano,
segnalo Bleu-blanc-rouge (1998); L'Enterrement de ma mère (2000),
Et Dieu seul sait comment je dors (2001); Verre cassé (2005).
[10] Henri Lopes, Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les
Gaulois. Simples discours, Paris, Gallimard, "Continents noirs",
2003, p. 44. Di Henri Lopes sono stati tradotti in italiano i seguenti
romanzi: Cercatore d'Afriche (Le Chercheur d'Afriques, 1990) a cura di
Mario Bensi (traduttore: G. Spiga), Milano, Jaca Book; 1994; Sull'altra
riva (Sur l'autre rive, 1992), Milano, Jaca book, 1996.
[11] Amadou Hampaté Bâ, L'interprete briccone. Tradotto da
Leonella Prato Cruso, Roma, Edizioni Lavoro, "Il lato dell'ombra
l'altra riva",1988. Traduz. inglese: The Fortunes of Wangrin, Bloomington,
Indiana University Press, 2000.
[12] Harald Weinrich, Conscience linguistique et lectures littéraires,
Paris, Maison des Sciences de l'Homme, 1990. In italiano è uscito
il saggio a cura di Cesare Segre, Lingua e linguaggio nei testi, Milano,
Feltrinelli, "Campi del sapere", 1988.
[13] Alain Ricard, Languages and Literatures of Africa. The Sands of Babel,
Oxford, Trenton, Cape Town/James Currey, Africa World Press, Dave Philip,
2004 (adattamento di Littératures d'Afrique noire, des langues
aux livres, Paris, Karthala, CNRS, 1995).
[14] I soli delle indipendenze. Tradotto da Monica Amari e Mario Bensi,
Milano, Jaca book, "Mondi Letterari, 1996; riedizione a cura di Mario
Bensi, Milano, e/o, "I Leoni", 2004.
[15] Pius Ngandu Nkashama, Le Pacte de sang, Paris, L'Harmattan, "Encres
noires", 1984.
[16] Texaco. Traduzione Antonella Colletta, Torino, Einaudi, 1994; riedizione
a cura di Sergio Atzeni, Nuoro, Il Maestrale, 2004.
[17] Milan Kundera, "Beau comme une rencontre multiple", L'Infini
n° 34 (été 1991), p. 50-62.
[18] Alexis Kagame, Indyohesha-birayi, Éditions Royales, Kabgayi,
1949. Tradotto da Anthère Nzabatinda, col titolo Le Relève-goût
des pommes de terre, Paris, Les Classiques africains, 2004.
[19] Jacques Chevrier, "Afrique(s)-sur-Seine: autour de la notion
de "migritude"", in Notre Librairie, n. 155-156, p. 13-18.
[20] Nata nel 1975 a Douala, Léonora Milano ha pubblicato nel 2005,
per i tipi di Plon (Parigi), il romanzo L'Intérieur de la nuit.
[21] Nimrod, "Un idiome de plus dans notre Babel", in Libération,
Supplément au n° 7730, jeudi 16 mars 2006, p. 17. Poeta, romanziere
e saggista, di Nimrod, non ancora tradotto in Italia, ricordiamo i romanzi
Les jambes d'Alice (2001), Le Départ (2005), la raccolta poetica
En saison, suivi de Pierre, poussière (2004) e il saggio Tombeau
de Léopold Sédar Senghor (2003).
[22] Achille F. Ngoye, Agence Black Bafoussa, Paris, Gallimard ("Série
Noire" 2413), 1996; Sorcellerie à bout portant, Paris, Gallimard
("Série Noire" 2486), 1998; Ballet noir à Château-Rouge,
Paris, Gallimard, 2001 ("Série noire" 2617) (tradotto
in tedesco col titolo Schwarzes Ballett in Château-Rouge, Frankfurt
am Main, Zebu Verlag, 2004).
[23] Cf. Sherry Simon, Le trafic des langues: traduction et culture dans
la littérature québécoise, Montréal, Boréal,
1994.
[24] Roland Barthes, Lezione inaugurale della cattedra di Semiologia letteraria
del Collège de France, pronunciata il 7 gennaio 1977.
[25] Abdouarahman A. Waberi, "Parce que je suis un pur produit postcolonial",
in Libération, Supplément au n° 7730, jeudi 16 mars
2006, p. 7. Il gioco di parole è ovviamente su César/Césaire.
Aimé Césaire, nato a Basse Pointe (Martinica) nel 1913,
è una delle figure più importanti della letteratura francofona,
nonché colui che ha inventato la parola "Négritude"
nel suo lungo poema in prosa Cahier d'un retour au pays natal (1939) (traduzione
italiana di Graziano Benelli: Diario del ritorno al paese natale. Testo
francese a fronte, Milano, Jaca Book, 2004).